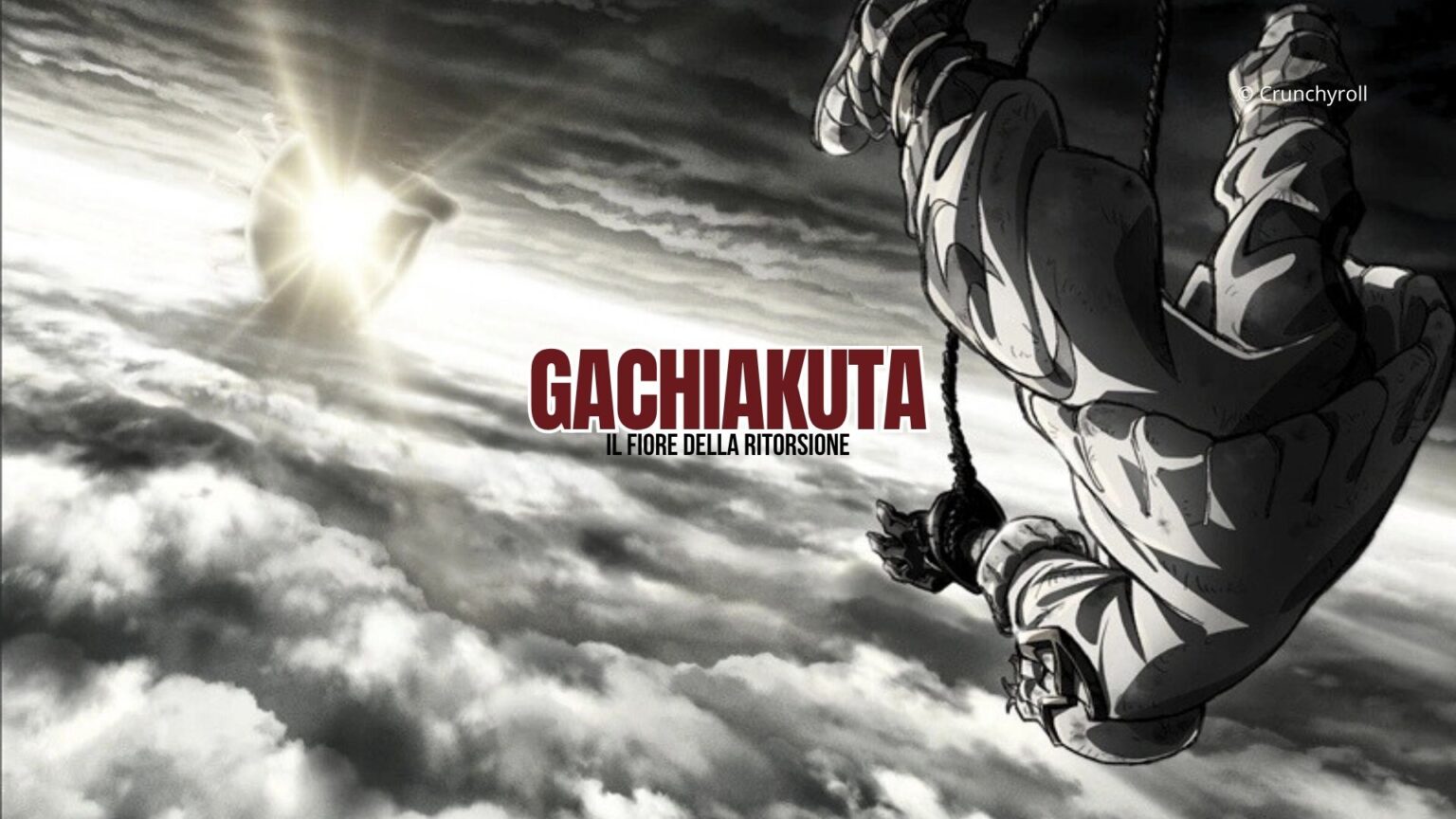Protagonisti impulsivi, poteri immensi, combattimenti spettacolari e una narrazione che – pur costellata da colpi di scena e tragedie – tende alla rassicurazione. A partire da Dragon Ball, passando per Naruto, Bleach, sino a toccare i recenti My Hero Academia o Jujutsu Kaisen, i canoni narrativi dei battle shonen si sono stratificati nel tempo, grazie a formule consolidate. In questo contesto ormai saturo, però, spicca un titolo nuovo che devia e riscrive il sentiero battuto: Gachiakuta, manga di Kei Urana e Hideyoshi Andou edito Star Comics, da poco approdato su Crunchyroll in veste di adattamento anime.
L’opera, così, si configura come una vera e propria dichiarazione di guerra all’omologazione del target. È sporca, ribelle, dolorosa, e ha deciso di imporsi nel panorama anime e manga con tavole graffianti, un’estetica disturbante e una storia che somiglia più a un grido di rivolta che a un confortante battle shonen. Ed eccoci qui, a esaminare i motivi che – secondo noi – rendono Gachiakuta un’opera originale, malgrado il suo legame con il canone.
Il Giver

Ai confini della civiltà, sopravvive un gruppo di reietti chiamati “tribali”, discendenti di criminali banditi dal mondo superiore. Tra loro c’è Rudo, un ragazzo dal temperamento ribelle, profondamente disgustato dagli sprechi e dall’arroganza della classe dominante. Il suo padre adottivo, Regto, gli ha sempre raccontato che il suo vero genitore fu gettato nel Baratro, un’immensa discarica sotto la città, come punizione per un fantomatico crimine.
Un giorno, però, Rudo trova Regto brutalmente assassinato. Nonostante la sua innocenza, viene subito incolpato del delitto, colpevole di essere un tribale. Senza possibilità di difendersi, viene condannato e scaraventato nel Baratro, proprio come suo padre. Sopravvissuto alla caduta, il giovane si risveglia in una distesa sconfinata e fetida, popolata da orrori composti di immondizia. Viene aggredito da queste creature, ma riesce a sopravvivere finché non viene soccorso da Enjin, conosciuto come “il Ripulitore”. Enjin gli svela che la Sfera, da cui proviene, non è il mondo reale, ma un sistema sospeso sopra la superficie. Dopo averne messo alla prova il coraggio, Enjin scopre che Rudo è un “Giver”, dotato della rara abilità di infondere vita negli oggetti e risvegliare da essi un potere nascosto.
Lo invita così a unirsi ai Ripulitori, un’organizzazione di Giver che affronta le mostruosità del Baratro usando armi vive chiamate “strumenti vitali”. Rudo accetta, deciso a padroneggiare questo nuovo potere e a usarlo per tornare nella Sfera, pronto a reclamare giustizia e vendetta contro coloro che lo hanno tradito.
Rudo

Partiamo dal protagonista, Rudo. Un giovane fiero e ostile, senza speranza e senza futuro, emarginato, cresciuto in un sistema che lo ha considerato “spazzatura” sin da subito. Al contrario di Naruto, che sogna di diventare Hokage, o Yuji, che combatte per proteggere i più deboli, Rudo non lotta per degli ideali. Non combatte per gloria o ambizione, ma per sopravvivere e dimostrare che chi è stato scartato dalla società ha il medesimo valore di qualsiasi altro individuo. Ma per farlo, ha bisogno di incanalare tutta questa rabbia in una vendetta degna del migliore dei villain, decidendo di agire con estrema lucidità.
Rudo, dunque, non è un eroe al pari di Deku, e il fuoco che arde dentro di lui ricorda a tratti il risentimento di Shigaraki. Eppure, anche lui come Midoriya incappa in una serie di individui “giusti” come Enjin, mentori piuttosto che malvagi manipolatori. Ed ecco che Rudo ribalta lo stereotipo shonen che vuole il protagonista buono, sempre ottimista, determinato a diventare una persona migliore. Il giovane Giver non è altro che un ragazzo ferito, emblema e baluardo delle umane debolezze.
L’Abisso e i Jinki

L’Abisso di Urana è una discarica in cui vengono gettati esseri umani considerati “inutili”, scarti della società, in una società in cui il valore degli individui si basa sulla loro utilità percepita. In tal senso, dunque, l’Abisso è una metafora sociale potente, visualizzata con coerenza dall’autrice. Rovine, lamiere, rottami, macerie e fumi tossici circondano il protagonista, trasmettendo un senso di precarietà e pericolo. È un luogo oppressivo, ma anche pieno di vita, poiché è qui che Rudo s’imbatte nei Ripulitori, sopravvissuti che hanno costruito un’esistenza ai margini, trasformando la spazzatura in un rifugio. Trovando qui la propria identità.
Ebbene, dimenticate antichi poteri, spade appartenute ad eroi, grimori. Come per Yuji in Jujutsu Kaisen, il potere di Rudo sta in qualcosa di “aberrante”, a tratti disgustoso. Le armi dei protagonisti in Gachiakuta, difatti, sono proprio quegli stessi oggetti di scarto che troviamo nell’Abisso: i Jinki, difficili da usare, ma necessari per combattere un potere “ordinario”. Armi grezze, spazzatura che si tramuta in potere, ma portatrici di un’Anima. La stessa autrice ha dichiarato che l’idea che gli oggetti personali possano assorbire emozioni nasce da un episodio in cui, da bambina, ruppe una penna a cui era molto legata. Nel primo volume del manga, Urana racconta non solo di aver provato dispiacere, ma anche di aver avuto l’impressione che l’oggetto soffrisse. I personaggi della storia instaurano legami profondi con oggetti carichi di Anima, inclusi quelli considerati spazzatura: una sorta di tsukumogami.
Difatti, il concetto espresso dagli tsukumogami riflette una visione del mondo in cui anche le cose materiali possiedono dignità e memoria (mottainai). Ogni oggetto porta con sé la traccia delle mani che l’hanno toccato, degli affetti e dei momenti vissuti. Anche la nozione degli “strumenti vitali” ha radici nella giovinezza dell’autrice, ispirata dagli umili appendiabiti forniti dalla nonna in tintoria, a sottolineare il tema ricorrente del valore nascosto nelle cose ritenute insignificanti o scartate. Il concetto espresso attraverso i Jinki è che anche tu, che sei un rifiuto, hai diritto di vivere. Non sono gli altri ad attribuirti valore.
Yokai del folklore giapponese, nati dalla credenza che ogni oggetto, dopo 100 anni di esistenza, possa acquisire un’anima e diventare senziente. Questa idea, sviluppatasi intorno al X secolo, attribuisce agli oggetti domestici un valore spirituale profondo, legato all’uso e alle emozioni delle persone che li hanno posseduti. Secondo la tradizione, lo spirito di un oggetto può assumere natura benevola o maligna a seconda di come è stato trattato. Questo ha portato alla nascita di riti come il kuyō, vere e proprie cerimonie funebri per oggetti ormai inutilizzati in cui si esprime gratitudine e rispetto prima della distruzione rituale.
La storia dentro la storia: graffiti e ribellione

Nonostante personalità come Horikoshi non siano mai state d’accordo, nel mondo degli shonen la leggibilità è tutto: un tratto chiaro, personaggi ben separati dallo sfondo, linee pulite, scene d’azione facilmente decifrabili. Tuttavia, Gachiakuta fa esattamente l’opposto. Ogni tavola sembra disegnata da un writer rabbioso, forte di linee spezzate, fondali strabordanti di dettagli, tratteggi ossessivi, immagini che sembrano esplodere. Tale scelta non è casuale, bensì rappresenta il mondo in cui si muovono i personaggi: l’Abisso, un luogo di rifiuti e di disperazione. E il pubblico viene trascinato senza filtri dentro questo caos visivo, costretto a orientarsi tra disordine e tensione.
Non c’è spazio per l’estetica fine a sé stessa, poiché l’arte di Kei Urana racconta una storia dentro la storia, mettendoci a disagio, puntando sull’impatto emotivo. E tale turbamento si percepisce non solo tra le pagine, bensì anche sullo schermo. Per questo motivo, l’autrice plasma il proprio universo narrativo con un’estetica punk, urbana e post-apocalittica, rara da vedere in uno shonen. Piercing, tatuaggi, abiti strappati, maschere, capelli rasati e accessori metallici sono emblema di ribellione interiore, di resistenza. A definire questo impatto visivo contribuiscono sia i disegni potenti di Urana, sia i graffiti urbani realizzati da Ando Hideyoshi, che arricchiscono l’opera con un linguaggio visivo crudo e vibrante.
Il character design nasce da un contrasto intenzionale: i personaggi dovevano essere “rispettabili”, ma nel disegnarli sono diventati stravaganti, fuori dagli schemi. E Urana ha accettato questa trasformazione, poiché lo stile dell’autrice, affinato durante la sua esperienza come assistente di Atsushi Ōkubo (Fire Force), evolve con la storia, rivelando un tratto dinamico e personale. Difatti, è soprattutto attraverso la propria arte che Gachiakuta comunica: ogni tavola, così come ogni episodio, trasmette emozioni senza bisogno di troppe parole. Ingiustizia, rabbia, sopravvivenza emergono visivamente dagli sguardi e i gesti dei personaggi, sovvertendo le regole del battle shonen. Dimostrando che l’immagine può raccontare più di dialoghi ben costruiti.
Caos e ostracizzazione

Anche le scene d’azione – sia manga, che anime – in Gachiakuta sfidano le regole del target. I combattimenti sono veloci, disorientano il pubblico con la loro crudezza e inquadrature che cambiano di continuo. L’ordine fa posto al caos in un’anarchia grafica che impatta e investe il malcapitato, scevra di inutili spiegoni. Una potenza visiva cui raramente ci siamo imbattuti prima d’ora, ma che fa da eco ad una feroce quanto aspra critica sociale.
E questo accade perché, sebbene Gachiakuta diserti il classico battle shonen anni 90, Urana non rinuncia a parlare di disuguaglianza, di marginalizzazione. Di un sistema malato e standardizzato che ostracizza il diverso anziché comprenderlo. Rudo e i Ripulitori sono il lerciume che tende a insudiciare l’illibatezza di un mondo moralista e fittizio, “ordinato”. E, pertanto, starà a loro innescare un meccanismo di rivolta dal basso, dalle viscere dell’umanità. Lì dove tutto sembra perduto, ecco che sboccia il fiore della ritorsione.