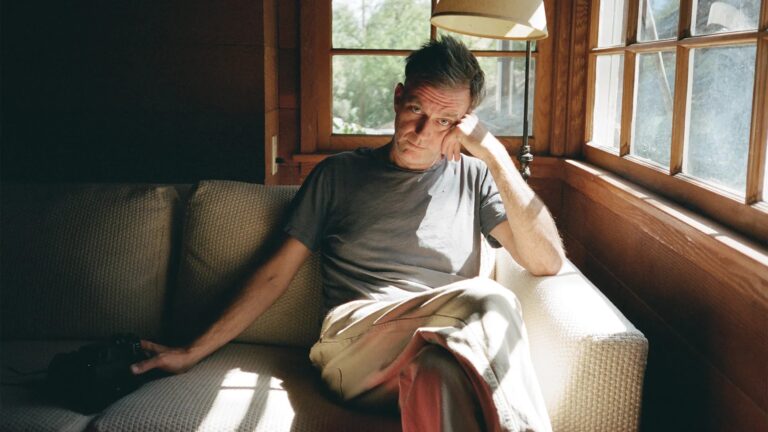Sin da tempi non sospetti, il K-pop è stato sinonimo di eccellenza, un fenomeno che ha conquistato milioni di fan in giro per il mondo. Il segreto? Un mix di coreografie impeccabili, canzoni e musiche in grado di catturare il pubblico. A questo, tuttavia, aggiungiamo beniamini patinati che paiono divinità scese in terra. Eppure, persino il lezioso mondo degli idol cela segreti indicibili.
Kpop Demon Hunters, il nuovo film Netflix che mescola fantasy, action e realtà, trasforma la brillante idol industry in un’arena di battaglie tra Bene e Male. Al tempo stesso, la pellicola promuove una pungente e ironica riflessione sulle dinamiche – spesso oppressive – che governano il kpop, un universo attanagliato da pressioni sociali e dinamiche complesse, spesso invisibili al grande pubblico.
Now I’m shining like I’m born to be

Rumi, Mira e Zoey sono le Huntrix, un trio di idol femminili che dominano le classifiche di tutto il mondo grazie alla loro splendida musica e le performance mozzafiato. Tuttavia, le giovani non sono semplici pop star, bensì delle vere e proprie “guerriere Sailor moderne”, Power Puff Girls contemporanee incaricate di combattere il potente Gwi-Ma e i suoi galoppini, decisi a conquistare il mondo impossessandosi delle anime degli umani. Cacciatrici di demoni in lustrini.
Tra un ramen istantaneo, un kimbap e un servizio fotografico, le paladine della giustizia, ereditiere di un potere immenso e tramandato da millenni, riescono sempre a sconfiggere il male e mantenere intatta la barriera dorata che separa il mondo umano da quello demoniaco. Un gioco da ragazzi per le Huntrix, nonché un passo in avanti per liberarsi definitivamente dalla minaccia dei demoni.
Ma, sorpresa-sorpresa, per opporsi alla potenza delle tre giovani, il malvagio Gwi-Ma decide di combattere nel loro territorio dando vita a una boy band: i Saja Boys, il cui leader Jinu sembra essere più determinato che mai. In poco tempo, i demoni in questione diventano la nemesi delle Huntrix, e le due fazioni si sfideranno in una battaglia epica a colpi di hit, rime e lame affilate. La musica diventa quindi una vera e propria arma e il destino dell’umanità si gioca a ritmo di Soda-Pop e Golden.
Tuttavia, sia Mira che Jinu custodiscono uno sporco segreto… che potrebbe cambiare definitivamente le sorti della guerra.
Il lato oscuro dell’idol system: la satira di KPOP Demon Hunters

Come ha fatto, dunque, KPOP Demon Hunters a sbaragliare qualsiasi altro produzione odierna?
Oltre alle animazioni atipiche e alle canzoni pensate per essere vere e proprie hit, la sua forza sta nella capacità di “andare oltre la superficie luccicante dell’industry” e di far luce sulle contraddizioni e le difficoltà del sistema idol, sebbene con estrema ironia. Rumi, leader delle Huntrix, è una mezza-demone che deve nascondere la sua vera natura per non essere allontanata. Tale scelta è metafora della pressione costante che avvertono idol e celebrities, costretti a conformarsi a un ideale di perfezione pressoché irraggiungibile, a nascondere fragilità e imperfezioni per mantenere un’immagine pubblica ideale.
Ansia da prestazione, allenamenti estenuanti, repressione di rabbia e frustrazione, controllo rigido sull’alimentazione, isolamento sociale e la costante necessità di mantenere un’immagine immacolata. Tutti questi elementi, imprescindibili per un vero idol, vengono qui spesso ridicolizzati e affrontati con sprezzante ironia. Tutto ciò perché spesso ci si dimentica che i nostri beniamini non sono solo performer, bensì esseri umani con le loro fragilità. Individui complessi, sfaccettati, messi sotto un microscopio sociale, con una vita privata quasi nulla e un’immagine costruita a tavolino dalle agenzie.
Le dinamiche tossiche degli idol: tra sfruttamento e immagine perfetta

Per comprendere a pieno la critica socio-culturale che si cela dietro Kpop Demon Hunters, è utile inquadrare il fenomeno idol nel suo contesto storico. Nato in Giappone negli anni ’60, il cosiddetto modello idol è oggi una vera e propria macchina-sforna-soldi, particolarmente potente in Corea del Sud, dove il K-pop figura quale industria multimiliardaria.
Essere un idol, tuttavia, significava molto più di “saper cantare e ballare”. Sin dagli anni 70, coloro che ne intraprendevano il cammino erano consapevoli di dover vendere l’anima al diavolo: proprio come accade a Jinu con il malvagio Gwi-Ma, non a caso rappresentato quale demonio divora anime. Costretti a firmare contratti vincolanti con agenzie potenti che gestiscono ogni aspetto della loro vita, gli artisti non hanno mai avuto granché voce in capitolo. Dall’immagine pubblica agli schemi comportamentali, dai rapporti sentimentali ai social media, fino a interventi di chirurgia estetica.
I trainee, ovvero gli apprendisti, trascorrono anni ad addestrarsi in programmi intensivi, spesso isolati dal mondo esterno, sottoposti a pressioni psicologiche e fisiche estreme. Non tutti riescono a debuttare e molti soffrono di ansia, depressione o problemi di salute fisica. Una volta giunti all’agognato debutto, la carriera di un idol è spesso breve e usa e getta. Generalmente, intorno ai 25 anni – considerata un’età “avanzata” nell’industria – si assiste al loro canto-del-cigno. Molti idol vengono sostituiti da volti più giovani e freschi, in un processo di ricambio continuo che sacrifica la crescita personale e la maturità a favore dell’immagine di gioventù eterna.
Il successo costruito e il prezzo della celebrità

Il percorso per diventare idol è inevitabilmente tortuoso: audizioni, allenamenti estenuanti, costante controllo e sacrificio. Il pubblico spesso non vede – o finge di non vedere – questo lato oscuro e si concentra solo sul prodotto finale: l’immagine perfetta sul palco, la voce impeccabile, la coreografia sincronizzata. Tuttavia – come accennato – questa immagine è fragile, spesso costruita a tavolino. Dietro i sorrisi smaglianti si nasconde un tessuto di dolore e impotenza, alienazione e perdita di identità.
Gli idol sono consumati rapidamente dal sistema che li ha creati, sostituiti da nuove promesse in un ciclo senza fine. Esempio lampante e disturbante di tale intercambiabilità potrebbe essere la cosiddetta “cerimonia di diploma” (sotsugyo-shiki), che segna il congedo di un membro dal gruppo: un momento doloroso che simboleggia la brevità di una carriera, una decisione fuori dal controllo dell’artista stesso. Sette anni di celebrità, sette anni di sacrifici, per poi cadere nuovamente nel dimenticatoio: capirete da voi che non tutti riescono a farsene una ragione.
L’immagine come prodotto

Difatti, più di ogni altra cosa, l’identità di un idol è costruita principalmente sull’immagine. Le agenzie impongono rigide regole comportamentali, sia a donne che a uomini. Niente fidanzati\e, niente trasgressioni, dieta rigorosa e un’immagine pubblica che deve rimanere castissima, divina, immacolata. Questo modello di perfezione a-ogni-costo, tuttavia, col tempo ha acceso un campanello d’allarme negli spettatori, tant’è che molte agenzie e major sono state accusate di sessualizzazione e sfruttamento, specialmente nel caso di performer minorenni.
Fa sorridere, dunque, l’improvviso cambio di look di Rumi a metà pellicola. Quando la giovane idol abbraccia il lato oscuro, demoniaco, la sua treccia perfetta si disfa, la postura è tutt’altro che perfetta, proprio come tutt’altro che perfetta è il portamento dei Saja Boys, spesso colti in atteggiamenti ricurvi e poco consoni al contesto k-pop. In tal senso, è interessante constatare quanto i membri del gruppo siano stereotipi viventi.
Le colpe del fandom

Nel 2018, Maho Yamaguchi (NGT48) fu aggredita da due fan all’interno del suo condominio. Il mese dopo rese pubblica la vicenda sui social, denunciando che i suoi dati erano stati divulgati da alcune colleghe e accusando il management di non aver agito. Dopo la denuncia, fu costretta a scusarsi pubblicamente, scatenando indignazione in Giappone e all’estero, accusando il manager di aver colpevolizzato la vittima. Oltretutto, la mancata punizione dei membri coinvolti spinse Yamaguchi a lasciare il gruppo.
Il fandom gioca un ruolo cruciale, ma spesso problematico. Eventi quali gli akushukai (i cosiddetti “incontri a stretta di mano”) danno vita a un legame artificiale e potenzialmente tossico tra supporter e i loro beniamini. Alcuni fan sviluppano comportamenti ossessivi, innamorandosi delle celebrità e reagendo con rabbia e violenza se il loro “oggetto di adorazione” infrange regole non scritte, come ad esempio “avere una relazione sentimentale” con qualcuno.
Episodi reali di stalking, aggressioni e umiliazioni pubbliche sono tristemente frequenti. Idol come Maho Yamaguchi e Minami Minegishi hanno vissuto esperienze drammatiche che mostrano come il confine tra affetto, supporto e possesso possano tramutarsi in vere e proprie minacce. D’altronde, altro tema centrale della pellicola sono proprio le relazioni tra fan e celebrity.
I fan sono rappresentati come adoranti ma anche potenzialmente ossessivi, alle dipendenze degli idol, data la loro reale capacità di trasformare il supporto in una forma di possesso tossico. E il film gioca con queste dinamiche, mostrando non solo gag esagerate e volutamente cringe che fanno sorridere, ma anche il lato più malato dell’adorazione. Dopotutto, il fine ultimo è denunciare questo mondo talvolta malato, con lo scopo di far riflettere sul labile confine tra ammirazione e controllo.
Difatti, Kpop Demon Hunters ci invita a guardare oltre il palco e le luci, a riconoscere il valore delle persone dietro l’immagine pubblica e a riflettere su cosa significhi davvero essere un “idolo delle folle”. Una visione consigliata non solo ai fan del K-pop ma a chiunque voglia comprendere meglio un fenomeno culturale che ha cambiato il volto dell’intrattenimento mondiale.
Identità coreana e animazioni 2D

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’estetica originale di questo film: un’esplosione di colori, coreografie elaborate, riprese dinamiche e una colonna sonora trascinante. L’animazione fonde elementi 3D con un forte richiamo all’estetica 2D degli anime, pur rinunciando completamente allo stile bidimensionale, come spiegato dalla regista Maggie Kang. Prodotto da Sony Pictures Imageworks, il film trae ispirazione da videoclip musicali, K-drama, fotografia editoriale. Il risultato è un’opera nuova e provocatoria dietro cui si cela una pungente critica all’industria idol e alle sue dinamiche disturbanti.
Kang e il team creativo hanno puntato a una resa visiva audace, utilizzando il linguaggio tridimensionale per rendere i personaggi “vivi”, puntando il focus soprattutto nella realizzazione dei loro volti. Josh Beveridge, responsabile dell’animazione, ha descritto come le espressioni siano state adattate ai diversi registri emotivi del film: dal glamour da popstar, ai momenti più aggressivi e spigolosi, fino alle sequenze volutamente ridicole in stile “Chibi”, con tratti iper-espressivi e caricaturali.
Particolare attenzione è stata data alla rappresentazione autentica dell’identità coreana: i Saja Boys sono rappresentazione della Morte, mentre qua e là sono seminati migliaia di dettagli tipici della Corea del Sud. Nonostante i personaggi parlino inglese, le forme di bocca e occhi sono state animate ispirandosi ai movimenti tipici del linguaggio coreano, per mantenere coerenza culturale e visiva. Il risultato è un’opera intensa, ritmata e stratificata, che combina intrattenimento e critica sociale. Un film in grado di emozionare lo spettatore, mostrandogli una realtà – spesso nascosta ma fondamentale – per comprendere il fenomeno globale del K-pop.