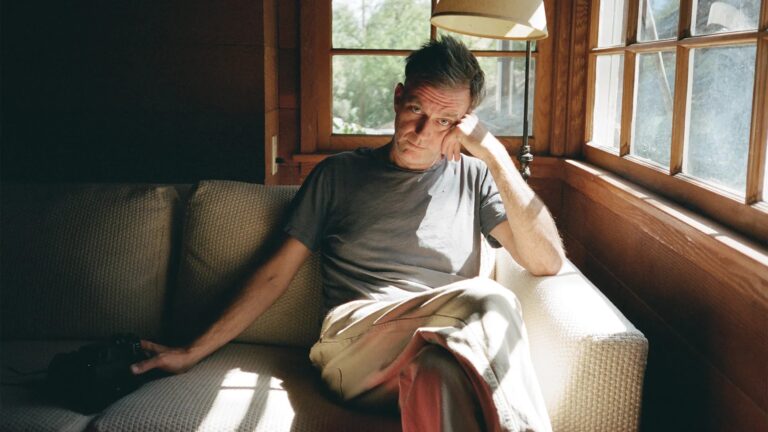Tra il 2018 e il 2021 almeno tre grandi autori internazionali si sono rivolti al passato e hanno attinto alle loro esperienze personali, forse per trovare, più o meno consapevolmente, una cesura e dare una nuova direzione alle loro filmografie. In altre parole per mettere un punto e a capo. Nel 2018 Cuarón lo fece con Roma, premiato nel 2019 con gli Oscar per la miglior regia, il miglior film straniero e per la miglior fotografia; lo hanno fatto Sorrentino e Branagh nel 2021, rispettivamente con È stata la mano di Dio e con Belfast, entrambi candidati all’Oscar: il primo per il miglior film internazionale, il secondo per vari premi importanti, tra cui miglior film e miglior regia. Ma in che modo questi tre autori, così diversi per latitudine di provenienza, esperienze e percorsi cinematografici, hanno declinato i loro Amarcord? Ci sono elementi in comune?
Un punto e a capo

Intanto possiamo già dire che con queste tre opere, il trittico di autori presi in esame ha dato una decisa virata alle proprie carriere, almeno apparentemente, verso tematiche e stili mai toccati prima d’ora. Il regista messicano premio Oscar, dopo due film di fantascienza ad alto budget, I figli degli uomini (2006) e Gravity (2013), caratterizzati da tour de force registici, con piano-sequenza sempre più acrobatici e vertiginosi, ripiega inaspettatamente su una vicenda della sua infanzia e mette al centro del film la giovane donna, di origini indigene, che gli fece da tata in giovanissima età.
Paolo Sorrentino, dopo film e serie iperbolici in cui si è occupato di figure potenti del mondo politico ed ecclesiastico (Andreotti ne Il divo, Berlusconi in Loro, il papa nelle serie The Young Pope e The New Pope) oppure della decadenza della città eterna, capitale dei vizi del nuovo millennio (La grande bellezza), si rivolge anch’egli al privato e mette in scena il più grande dolore che lo abbia mai colpito: la perdita improvvisa dei genitori in giovane età. Tra l’altro tornando nella sua città natia, a vent’anni dall’esordio de L’uomo in più (2001), unica pellicola sorrentiniana ambientata a Napoli prima della mano di Dio.

Infine Branagh, dopo innumerevoli, validi adattamenti e variazioni sul tema shakespeariano sembrava aver smarrito la sua vena più squisitamente autoriale per dedicarsi a grosse produzioni mainstream, per la Marvel (con il primo Thor) e per la Disney (Cenerentola e Artemis Fowl), oppure al suo Christie-verse, l’universo cinematografico dedicato ai romanzi della più famosa scrittrice di gialli mai esistita. Invece con Belfast costruisce un racconto intimo e al tempo stesso corale, sulla sua infanzia nella capitale dell’Irlanda del Nord, funestata dall’inizio dei cosiddetti Troubles, ovvero gli scontri sanguinosi tra protestanti e cattolici, sfociati poi in anni di terrorismo ad opera dell’IRA e ritorsioni violente da parte del governo inglese.
La Storia con la esse maiuscola

Nelle opere di almeno due dei tre autori entra in gioco la Storia, quella con la esse maiuscola per intenderci. In Roma assistiamo ai disordini del 10 Giugno 1971, giornata del Corpus Christi in cui squadracce paramilitari, Los Halcones, massacrarono gli studenti dimostranti a Città del Messico. Per tutto il film inoltre Cuarón pone l’occhio sulle differenze di classe tra Cleo, la protagonista di origini indigene, e la famiglia borghese dei suoi datori di lavoro, discendenti dei conquistatori spagnoli.
In Branagh, i primi scontri nella Belfast del 1969 tra lealisti protestanti e cattolici entrano prepotentemente nella vita del piccolo Buddy, alter-ego dell’attore e regista irlandese, imprimendo una nuova direzione alla sua vita e a quella della sua famiglia.
In Sorrentino invece il racconto vive maggiormente di momenti privati e la Storia vi entra solo tramite la figura, mitica e idealizzata, di Maradona, responsabile indirettamente della sopravvivenza del giovane Fabietto ai suoi genitori.
L’appartenenza

Una cosa accomuna tutte e tre le opere e cioè il loro essere segnate da caratteristiche tipicamente nazionali dei loro personaggi: i nativi del Messico in Roma, la comunità protestante irlandese a Belfast (“Gli irlandesi sono nati per emigrare, o nel resto del mondo non ci sarebbero i pub” afferma l’amica della mamma di Buddy) e la famiglia napoletana medioborghese, ma caciarona come e più di quelle popolari, in È stata la mano di Dio. I tratti più marcatamente nazionali vengono messi orgogliosamente in rilevo in ognuna di queste pellicole, quasi a rivendicare un’appartenenza imprescindibile, per ognuno dei tre autori, a una terra e a un luogo in particolare, nonostante l’internazionalità delle loro carriere. Insomma il sangue d’origine torna a farsi sentire e il ritorno alle radici sembra quasi una necessità insopprimibile per il percorso interiore di questi tre cineasti.
Una cosa però accomuna le famiglie dei film di Cuarón e Sorrentino e cioè il tradimento coniugale da parte del padre. Mentre in Roma tale evento porta addirittura all’abbandono della famiglia da parte del padre, ma è anche all’origine di un’inedita solidarietà femminile tra la tata Cleo e Sofia, la moglie borghese tradita, suggellata dallo splendido abbraccio collettivo in riva al mare, in È stata la mano di Dio il tradimento viene riassorbito in nome di un tacito accordo tra coniugi che prevede un periodo di allontanamento e poi un riavvicinamento.
Il cinema

Il gusto per il cinema vissuto da spettatore (poco presente nel film di Cuarón se non in un paio di scene in cui Cleo va in una sala) diventa in Belfast e in È stata la mano di Dio rifugio da una realtà difficile o, per dirla alla Sorrentino, ‘scadente’. Mentre nel film di Branagh la fruizione cinematografica ha una funzione ludica, affabulante, ovvero di scoperta del meraviglioso, del fiabesco e dell’avventura (soprattutto in chiave western), in Sorrentino il cinema diventa doloroso strumento di catarsi, riscatto ed emancipazione.
Continuità nella discontinuità

Apparentemente anche dal punto di vista stilistico i tre film segnano una discontinuità per i tre autori: bianco e nero ‘castigato’ per Cuarón e Branagh (anche se quest’ultimo lo aveva usato nel 1995 in Nel bel mezzo di un gelido Inverno, ma con un senso diverso), regia più sommessa e invisibile per Sorrentino, che ci aveva abituati a virtuosismi visivi che erano diventati il suo marchio d’autore. In realtà nessuno dei tre cineasti rinuncia alle proprie cifre stilistiche.
Cuarón fa ampio uso anche in Roma dei virtuosistici piano-sequenza che avevano fatto strabiliare cinefili, critici e membri dell’Academy nelle sue pellicole fantascientifiche. Nel film messicano però i long-take acquistano un senso ben preciso: panoramiche a 360 gradi con cui Cuarón fa immergere lo spettatore negli ambienti della sua città natale, oppure lunghi carrelli laterali (travelling) durante i quali succede sempre qualcosa che trasformerà le vite di Cleo e della famiglia di cui si prende cura. È proprio su questi due movimenti, circolare e laterale, che si declinano gli eventi emotivi del film: le panoramiche a 360 gradi descrivono ambienti (la casa in cui lavora la protagonista, la festa di capodanno in cui si sente estranea, la strage vista dall’interno del centro commerciale) in cui Cleo non ha vie di uscita e la circolarità non serve altro che a chiuderla in un destino senza sbocchi. Nelle scene caratterizzate dai lunghi carrelli laterali Cleo invece diventa attiva e trasforma il suo fato, quasi come se il movimento non più chiuso della macchina da presa, ma invece aperto e direzionale, che va da un punto A ad un punto B, costituisca anche un percorso interiore di trasformazione che porterà alla catarsi della bellissima scena finale.

Il film di Sorrentino inizia anch’esso con un notevole virtuosismo, un lungo piano-sequenza, tra l’altro girato in elicottero, in cui la camera si avvicina al lungomare di Napoli, giusto il tempo di inquadrare la solitaria auto d’epoca di San Gennaro/Enzo De Caro, per poi allontanarsene improvvisamente, prendendo la via del mare aperto. Come abbiamo già scritto in un precedente articolo sui simboli di Napoli, questo scarto corrisponderebbe anche ad un movimento emotivo di Sorrentino nei confronti della propria città, verso la quale molti dei suoi figli provano attrazione e repulsione al tempo stesso. Anche nel resto del film, sebbene non in forma radicale, ritroviamo quelle caratteristiche tipiche del cinema di Sorrentino, ovvero le sospensioni oniriche del racconto, o il modo di entrare in una scena tramite un elemento sorprendente, una faccia o un dettaglio decontestualizzato che disorienta lo spettatore, finché non gli vengono fornite ulteriori coordinate.
In Branagh la messa in scena riflette in tutto e per tutto il suo amore per il teatro e infatti il piccolo Buddy, nonché i suoi familiari, sembrano vivere costantemente su un palcoscenico, alla costante ricerca della battuta ad effetto, della massima da ricordare. Lo stile registico, sebbene camuffato dall’impianto intimo della storia, è in realtà muscolare come quello delle sue produzioni ad alto budget: ampio uso di ralenti, ipermobilità della macchina da presa che volteggia attorno a Buddy e agli altri personaggi in modo vertiginoso, ampio uso di droni per inquadrature a volo d’uccello sui sobborghi di Belfast e, a piombo, sugli scontri in strada: in particolare si veda lo ‘stallo alla messicana’ tra il padre di Buddy e il lealista che tiene in ostaggio moglie e figlio.
La madre

L’archetipo materno infine è più o meno preponderante in tutti e tre i film, ma declinato diversamente. In Cuarón diventa il simbolo di una maternità ricercata e violentemente negata per Cleo, ma comunque esperita tramite l’accudimento dei figli di Sofia. In È stata la mano di Dio la madre è idealizzata al punto da renderla giocoliera nonché esecutrice di elaborati scherzi ai danni dei vicini e del marito. Non dimentichiamo il rovescio della medaglia nella scena in cui è preda di violente crisi isteriche, rispecchiate patologicamente in Fabietto, dopo l’ennesima telefonata dell’amante del marito. Anche in Belfast c’è una versione idealizzata della madre, che si dà in volteggi ballerini col papà, sulle note di Everlasting love. Nel film di Branagh, però, la madre, legata in maniera viscerale alla sua terra, pone un ricatto emotivo al marito, imponendogli di rimanere in una città e in un quartiere ormai rischiosi per la vita dei figli, pur di non sradicarli da un ambiente familiare. Tutto questo almeno fino all’evento traumatico che la convincerà del contrario.
Guardarsi indietro per andare avanti

I tre cineasti presi in considerazione, rivolgendosi al proprio vissuto personale, più o meno connesso con eventi storici, hanno dato delle direzioni nuove alle loro carriere. Sarà interessante scoprire se con le prossime opere proseguiranno ulteriormente su binari mai percorsi, oppure si dirotteranno su strade già battute. Più difficile invece individuare le ragioni che hanno spinto questi autori a guardarsi indietro, per andare avanti. Forse proprio in questa contraddizione giace la ragione ultima: arrivati nel mezzo del cammin di nostra vita (per Branagh magari un po’ più di metà), si fanno i primi bilanci e ci si rivolge al proprio passato per capire da dove si proviene e, soprattutto, per guardare al futuro.
Come abbiamo visto, le tre opere esaminate, sebbene segnino una frattura, almeno dal punto di vista dei temi trattati, nelle filmografie dei tre cineasti, in realtà ne rappresentano anche una continuità di cifre stilistiche e di modalità di messa in scena, quindi anche, in un certo senso, di sguardo sul mondo. In attesa di scoprire cosa farà Steven Spielberg con il suo film dalle connotazioni autobiografiche, The Fableman, in cui è stato coinvolto come attore anche il collega David Lynch, siamo curiosi di scoprire se il 27 Marzo anche Sorrentino e Branagh, come Cuarón, vedranno le loro autobiografie romanzate, insignite di un premio Oscar.