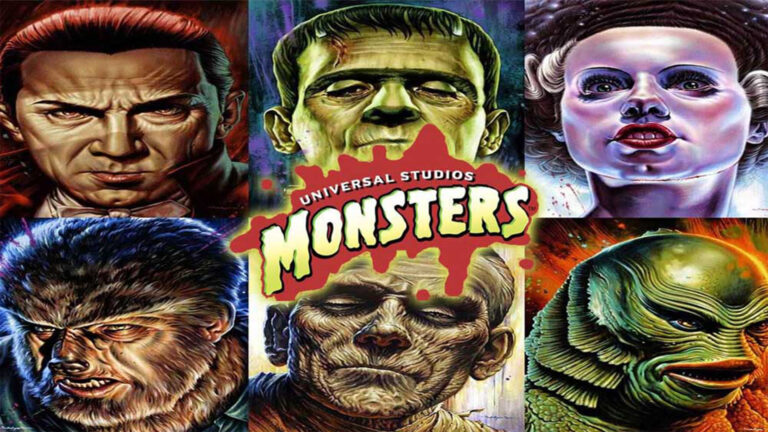A partire dal 14 luglio torna in sala con Cat People Quattro mosche di velluto grigio, il film cult del 1971 diretto da Dario Argento. Il capitolo conclusivo della trilogia degli animali esce nuovamente al cinema grazie al restauro in 4k effettuato dalla Cineteca di Bologna con la supervisione del maestro della luce Luciano Tovoli. Il film che determina la soglia tra la produzione thriller e l’entrata nel puro horror è un’opera complessa e ricca di citazioni, dalla psicanalisi all’arte figurativa.
4 mosche di velluto grigio ha delle radici autobiografiche: Dario Argento voleva mettere in scena la crisi con la prima moglie per esorcizzare il suo dolore. Il protagonista interpretato da Michael Brandon, infatti, venne scelto per la sua somiglianza al regista.
Roberto (Michael Brandon) è un batterista rock che si accorge di essere seguito da uno strano individuo. Una sera, di ritorno dalle prove con la sua band, decide di fronteggiare lo stalker: durante una colluttazione molto intensa, Roberto lo uccide. Da questo momento in poi, l’uomo inizia a esser pedinato e ricattato da un altro misterioso soggetto che ha le prove per incastrarlo. Per non cadere in un vortice di follia e paranoia, Roberto chiede aiuto alla compagna Nina (Mimsy Farmer), al suo amico Diomede (Bud Spencer) e all’eccentrico ispettore Arrosio (Jean-Pierre Marielle).
Fare e disfare il giallo

Quando esce 4 mosche di velluto grigio Dario Argento si sta imponendo come autore a tutti gli effetti. L’uccello dalle piume di cristallo e Il gatto e nove code avevano avuto un grosso successo di pubblico e anche all’estero il giallo italiano conquistava gli spettatori, tanto che la grande Paramount Pictures decide di distribuire i suoi film negli USA.
Nello stesso periodo, in Italia iniziano a fiorire tutta una serie di titoli “imitatori” ispirati al mondo della natura e degli animali – come Una farfalla dalle ali insanguinate o Tarantola dal ventre nero.
4 mosche si sviluppa come il più classico dei gialli: c’è un protagonista pedinato che si improvvisa detective, c’è un misterioso killer con guanti neri e cappotto, presagi di morte dietro ogni angolo. La differenza sostanziale è il ribaltamento dell’innocenza del protagonista, dato che Roberto (almeno apparentemente) si macchia di omicidio.
L’occhio che uccide

L’opera di Argento vive al confine di mondi interiori, scrutando tra le soggettive del killer nei flashback della sua infanzia fino all’obiettivo fotografico con cui inchioda la sua vittima. 4 mosche è un gioco di sguardi: il protagonista entra in una vorticosa spirale di soggettività e identificazione tra vittima e carnefici. Allo stesso tempo, le quattro mosche che danno titolo al film identificano lo spietato assassino. Lo sguardo uccide, ma grazie agli avanguardistici stratagemmi polizieschi accusa e svela i colpevoli.
Il ragionamento sull’identificazione sta anche negli aspetti freudiani del film: la psicanalisi, infatti, è il tema scientifico dell’opera, come l’ornitologia e la genetica lo sono per i primi due film della trilogia. Il senso di colpa e la paranoia rendono Roberto un protagonista inquieto perché colpevole, tanto da recarsi da uno psichiatra. Ma anche la rivelazione dell’assassino, senza fare spoiler, sta tutta in un’architettura di trauma, colpa e psicosi. La discesa negli inferi dell’oscurità di Argento sembra calarsi proprio nell’abisso della mente umana, tracciando una linea netta nella filmografia dell’autore.
A compiere la cesura è soprattutto la musica, e lo spettacolo insieme a essa: è dentro un teatro vuoto che avviene l’omicidio di cui si macchia Roberto e l’unico testimone indossa proprio una maschera dalle sembianze infantili. La complessità della performance artistica e il suo collegamento con la psiche umana sono temi ricorrenti nei thriller italiani (basti pensare a Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri, segno di un cinema colto e attento alla cultura attuale, anche se di genere). Nelle intenzioni del regista, i toni di quel vortice senza uscita sarebbero dovuti essere dei Deep Purple, ma sono stati affidati a Ennio Morricone. Il maestro riesce a costruire una tessitura sonora che non solo dà vita a momenti cult (l’Hallelujah, su tutti), ma scandisce con forza dirompente la discesa del protagonista negli abissi della paranoia.
Tra libertà creativa e attualità

Il Cinema di Dario Argento è un’arte sottile, sorretta dal tempo nel catturare istanti dal fascino magnetico. La macchina da presa si fonde con la storia, catturando l’angoscia e il sentire con soluzioni innovative. Tra stacchi improvvisi e istanti da brivido, il film squarcia lo schermo con la sua elegante brutalità.
L’attualità di 4 mosche di velluto grigio sta nella libertà di Argento di muoversi in un terreno cinematografico fertile, dove la sperimentazione di genere è ben accolta e incoraggiata. Non c’è timore nel giocare con la religione, con il concetto di bene e male che a volte si intrecciano profondamente senza risoluzione catartica. Il risultato è un film di estrema attualità, un’opera che intrattiene, inquieta e prelude come il più dolce dei sussurri ai più grandi capolavori di tutta la filmografia del regista. Un’occasione da non perdere sul grande schermo.
Conclusioni
Il terzo film di Dario Argento è un giallo che porta lo spettatore negli abissi della psiche umana con il suo ritmo rock e spiazzante.
Pro
- La colonna sonora di Ennio Morricone dà un ritmo indimenticabile alla suspense
- I personaggi sono soggetti vivaci e sfaccettati
Contro
- La potenza di certe soluzioni visive potrebbe disturbare un certo tipo di pubblico
-
Voto ScreenWorld