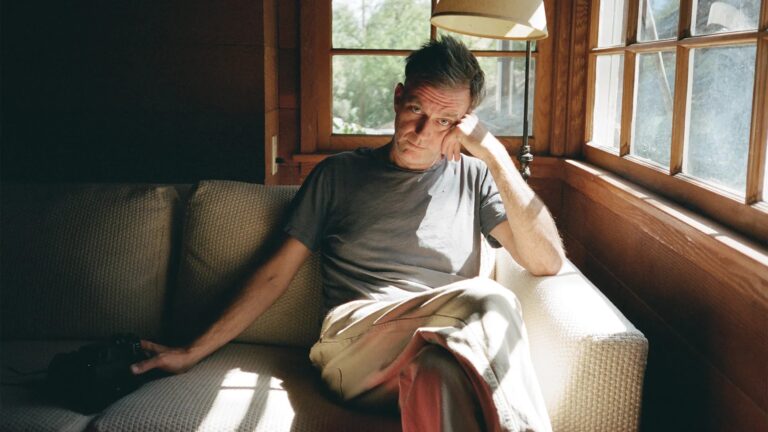L’acqua è limpida. Lo schermo è profondo quanto l’oceano. James Cameron ci invita a tuffarci, a nuotare a occhi aperti. Imparare a respirare di nuovo per i Na’vi. Tornare a vedere di nuovo per noi gente del cielo. Il cinema che torna esperienza collettiva, tribale, sociale. Il cinema come collante tra le persone. Tutto in un tempo in cui avevamo dimenticato troppo. Dimenticato il rituale della proiezione, lo stare insieme, lo stare davanti a uno schermo più grande di una decina di pollici. A James Cameron piace lanciare sfide e cambiare le cose. Questa volta, però, non è soltanto merito di un sequel più ricco del primo Avatar o di un film in cui la prospettiva passa dal viaggio dell’eroe al cammino di una famiglia intera (come abbiamo visto nella nostra recensione del film).
No, Avatar – La via dell’acqua è un urlo nel deserto. Il richiamo possente a tornare in sala per ricordarci cosa è davvero il cinema. Per farlo serviva purezza, senso di meraviglia e voglia di stupire. Perché in un tempo dominato dalla fruizione domestica e dalla dittatura delle serie tv, abbiamo adottato una percezione distorta delle cose che guardiamo. Abbuffati di colpi di scena, storie complesse da seguire, universi condivisi e caccia ai buchi di sceneggiatura, per troppo tempo abbiamo pensato che la trama fosse la regina indiscussa dell’audiovisivo. James Cameron è tornato per toglierle la corona e ricordarci l’anima più primitiva del cinema.
Raccontare per immagini: la via del cinema
![]()
“Io ti vedo” per dire “ti amo” è l’essenza di Avatar. Lo è sempre stato. La sua dichiarazione di intenti lampante fin dal primo film. Per James Cameron il cinema è soprattutto questo: vedere, mostrare, veicolare emozioni con la potenza delle immagini, non con la forza delle parole. E non è un caso che questo sequel sia ambientato sott’acqua, dove si parla con i gesti. E sono proprio i gesti a fare di Avatar – La via dell’acqua un film di grandiosa purezza cinematografica. Sublime quando emoziona solo con le luci, le forme, volti espressivi che piangono e sorridono, mani tese, occhi grandi e creature con un’anima anche se incapaci di parlare. A cosa serve una storia complessa quando bastano le immagini per scuotere? Perché pretendere una trama intricata quando il film ti sta invitando dentro un altro mondo?
Davvero abbiamo dimenticato la forza primordiale del cinema? Questo sembra chiedersi James Cameron fin dal 2009, da quando anche il primo Avatar celebrava una visione tribale dello stare insieme per puntare all’essenza delle cose. E il cinema nasce così: muto. Solo immagini in movimento. Immagini e movimento. Così, mentre Jake scava alla ricerca della sua vera natura, noi viaggiamo assieme a lui alla riscoperta di quella più autentica del cinema stesso. Questa volta, però, non è il viaggio del singolo, ma di una famiglia intera. Che era quello che mancava a tutti noi dopo la pandemia: andare al cinema e vivere quel rituale assieme ad altre persone. Se è vero che “la via dell’acqua connette tutte le cose”, James Cameron ha creato di nuovo un modo per farci stare insieme nello stesso posto: un meraviglioso altrove in cui tornare a meravigliarci per un grande schermo accogliente e immersivo come non mai.
Iceberg: la scrittura sommersa
![]()
Come per il primo film, anche questa volta c’è una critica unanime nei confronti del lavoro di Cameron. Indovinate un po’? Sempre lei: sua maestà la trama. Troppo banale, troppo scarna, troppo simile a quella di Avatar. Ma è davvero così? Proviamo a confutare tutto un pezzo per volta. Avatar – La via dell’acqua sceglie ancora una trama essenziale, semplice, ma non per questo superficiale. Perché se è vero che la trama è asciutta, la potenza tematica del film è impregnata di significati. Questa è una storia che parla di fiducia nel futuro, di empatia e di genitori che imparano dai figli mettendosi in discussione. Molto più ricco del suo predecessore, il secondo Avatar abbraccia molti più personaggi in conflitto. Jake non è più il classico eroe in formazione, ma un padre che deve rivedere il suo concetto troppo militare e ancorato alla tradizione terrestre di genitore. Lo stesso vale per la territorial Neytiri, madre amorevole ma contradditoria nella non accettazione del diverso al cospetto del figlio adottivo Spike (colpevole di essere umano). E come dimenticare i due giovani Lo’ak e Kiri, figli alle prese con le loro solitudini o un personaggio in apparenza mono-dimensionale come il colonnello Quaritch costretto a smussare i suoi angoli per convivere con un nuovo corpo e con Pandora.
Se la struttura della storia è simile (minaccia umana, fuga, bisogno di imparare dei protagonisti, battaglia finale), le vie intraprese per raccontarla sono molto di più e molto diverse. Perché James Cameron sa che nel cinema il “come racconti” è sempre più importante “del cosa racconti”. Anche perché la scrittura in Avatar è davvero un iceberg “dritto davanti a noi”: un punta visibile che nasconde un colosso subacqueo. Perché Cameron ha curato ogni singolo aspetto della sua mitologia aliena, impreziosendo Pandora di una marea di dettagli molto significativi. Fateci caso, il secondo Avatar racconta una comunità intera attraverso le immagini: basta la postura del corpo, un modo di camminare o di combattere per evocare una cultura intera. Succede con i Metkayina, la vera grande novità del sequel. Popolo con un aspetto nuovo, usanze nuove, che preferisce dare colpi di coda al posto dei pugni in una rissa. Un piccolo dettaglio che racconta un popolo. Ecco, anche questa è scrittura. Sommersa, ma percepibile attraverso la messa in cena. Il cinema puro, appunto.
Una visione modulare

Sfatiamo un altro mito. Perché la scrittura di questo Avatar – La via dell’acqua è molto meno banale e pigra di quanto si dica in giro. Per informazioni rivolgersi a quel vecchio volpone di James Cameron, che non lascia niente al caso e non dà niente per scontato. Nemmeno che la gente si ricordasse bene di Avatar. Cameron sa che sono passati 13 anni. Tanto, troppo tempo in un’epoca in cui l’intrattenimento ci bombarda di contenuti (seriali, soprattutto). E visto che il nostro intende il cinema come arte popolare, ha sempre il pubblico al centro dei suoi interessi. Così ha concepito un blockbuster modulare, molto atipico nella struttura. In che senso? Avatar – La via dell’acqua funziona come puro sequel diretto, ma è anche furbo nel ripetere concetti fondamentali sul funzionamento di Pandora (la vera protagonista della saga) già affrontati nel primo film. Per cui è un’opera fruibile, godibile e comprensibile anche senza aver visto il film precedente. E ovviamente, come se non bastasse, è anche un film aperto a un seguito (come sappiamo ce ne sono altri tre in cantiere), che funge quindi da reboot in ottica seriale. Ecco la stramba chimera di James Cameron: un sequel che vale anche come stand-alone con finalità da reboot. Merito di un regista che ha pensato a tutto e a tutti: ha creato un ponte col passato, si fa bastare il presente e pensa al futuro. Perché James Cameron forse non è il futuro del cinema (troppo irraggiungibile), ma è il futuro nel cinema. Un cinema che finalmente respira a pieni polmoni anche in apnea.