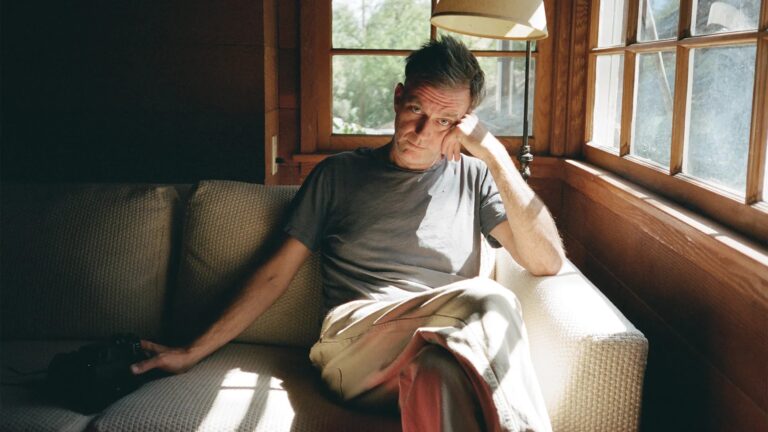Quando Blade Runner uscì nelle sale nel 1982, non fu accolto con entusiasmo né dalla critica né dal grande pubblico; anzi, fu considerato un vero e proprio flop. Il suo ritmo lento e riflessivo, insieme all’ambientazione distopica e oscura, risultarono stranianti per gli spettatori, abituati a una fantascienza più lineare e rassicurante. Nello stesso anno, il successo di E.T. e Star Trek II dimostrava infatti che il pubblico mainstream prediligeva narrazioni positive e ottimistiche, mentre l’opera di Ridley Scott appariva troppo cupa e criptica. Tuttavia, furono proprio questi elementi a farla rivalutare nel tempo come una delle opere cinematografiche più importanti di sempre.
Più che un semplice adattamento del romanzo di Philip K. Dick, il film si configura come un’esperienza visiva e concettuale. Parliamo di un neo-noir calato in un mondo cyberpunk, con un focus ben preciso sulle profonde questioni esistenziali che affliggono l’essere umano. Un’opera in grado di affrontare le tematiche futuristiche – e sempre più attuali – del romanzo di Dick, senza sconfinare nella classica spettacolarizzazione hollywoodiana. Il film è carico di una tensione etica ed esistenziale che va oltre i confini della fantascienza tradizionale, assumendo i contorni di una premonizione. Il concetto di vero e falso, insieme alla riflessione sulla natura stessa dell’esistenza, pone le basi per un discorso profondo sull’essere umano che oggi appare più necessario che mai.
Con l’evoluzione delle intelligenze artificiali, ci stiamo avvicinando a una realtà in cui le macchine potrebbero simulare relazioni, emozioni e pensieri. In questo contesto, le domande sollevate da Blade Runner diventano centrali: cosa significa essere umani? Qual è il confine tra naturale e artificiale? In questo senso, può essere utile richiamare le tesi di Martin Heidegger, uno dei maggiori pensatori del ’900 per quanto riguarda la questione dell’essere. Rileggere Blade Runner alla luce di queste tesi – in particolare quelle legate all’opera magna Essere e tempo – significa riconoscere nel film tutti quegli spunti filosofici che ne hanno costituito l’anima e il successo. Spunti che ci spingono a interrogarci non solo sulla nostra condizione presente, ma soprattutto su quella futura.
Il Dasein come concetto di uomo

Il filosofo tedesco, in Essere e tempo, riparte dalla domanda più antica della filosofia: che cos’è l’essere? Accusa i filosofi più moderni di aver affrontato la questione da un punto di vista superficiale, troppo dipendente dagli enti. Secondo Heidegger, l’uomo, o come da sua definizione il Dasein, è l’unico ente in grado di avere comprensione dell’essere. Una delle questioni fondamentali che caratterizzano questa visione è che il Dasein, contrariamente a quanto si possa pensare, nasce immerso nel mondo, ovvero all’interno di una rete di strumenti e relazioni. Dunque, l’essere non è mai solo, ma forzato da una serie di collegamenti da cui, inevitabilmente, dipende. Allora l’essere è un Essere-nel-mondo (In-der-Welt-sein) e, nello stesso tempo, è un Essere-con gli altri (Mitsein).
Distinguiamo allora l’essere umano e “reale” Rick Deckard, dal replicante e “fittizio” Roy Batty. È interessante notare come, almeno inizialmente, sia proprio Deckard a mostrarsi riluttante nel riflettere sulla propria condizione esistenziale, facendo di tutto per rifiutare sia il mondo in cui vive, da cui sembra completamente alienato, sia le relazioni poste al suo interno. Mentre Batty, fin da subito, si rivela completamente cosciente di essere parte di un mondo che l’ha creato e di essere inevitabilmente legato al suo creatore, Tyrell. Un momento emblematico della “consapevolezza” dei replicanti è rappresentato dal test Voight-Kampff, una serie di domande e misurazioni atte a distinguere gli androidi dagli umani, basato proprio sulla consapevolezza del mondo e del grado di empatia, teoricamente minore, degli androidi.
Il test per identificare i replicanti prende ispirazione dal test di Turing, ma anche da studi di psicologia comportamentale.
L’investigazione, così, diventa una vera e propria parabola di un viaggio attraverso la consapevolezza di Deckard – che, non a caso, potrebbe o non potrebbe confondersi con gli stessi androidi a cui dà la caccia. Costretto ad affrontare i replicanti e il mondo che li contiene, si avvicinerà sempre di più all’In-der-Welt-sein, scoprendo quanto sia labile il confine tra vero e artificiale, e ragionando invece in qualità di essere pensante, consapevole delle cose che lo circondano. Il Dasein, infatti, si apre al mondo proprio attraverso tre elementi: comprensione, affettività e discorso. Capire il possibile, provare emozioni e discorrere del senso delle cose diventano gli elementi essenziali per guidare Deckard verso la consapevolezza del mondo e di sé.
Essere è tempo

Un altro elemento fondamentale che definisce il Dasein è la sua relazione con il tempo. Per il filosofo tedesco, l’esserci è anche l’essere-per-la-morte (Sein-zum-Tode). L’essere umano è infatti l’unica esistenza in grado di comprendere la propria finitezza, eppure è proprio questo limite a renderlo ciò che è, ponendo la sua esistenza in un rapporto diretto con il tempo. Secondo Heidegger, questa consapevolezza non porta necessariamente alla disperazione ma rappresenta una condizione essenziale affinché l’uomo possa confrontarsi con il senso profondo del proprio essere. L’esistenza, in questa ottica, non è mai compiuta ma un continuo divenire di possibilità nella costante della morte.
Ed è proprio il tempo a distinguere gli androidi dagli umani. I replicanti sono infatti programmati per vivere solo quattro anni: un limite imposto dalla Tyrell Corporation per evitare che sviluppino emozioni complesse o una vera coscienza. Questa scelta narrativa, frutto dell’adattamento cinematografico di Hampton Fancher e David Webb Peoples, serve a esaltare il significato della vita e della morte, sia per le macchine che per gli esseri umani. Sarà infatti proprio a causa di questo limite che nascerà nei replicanti una consapevolezza del tempo, costituendo una vera e propria coscienza e spingendo i replicanti a ribellarsi, assurgendo alla figura di un Dasein autentico.
Nel corso della storia, i quattro androidi fuggitivi – Zhora, Leon, Pris e Roy Batty – sfidano infatti il loro destino. Ognuno, progettato per uno scopo preciso, sviluppa una volontà individuale attraverso le relazioni e il mondo. La loro umanità emerge proprio dalla loro esperienza di vita e dalla consapevolezza della propria finitezza. Perché ciò che definisce davvero l’essere sono le sue memorie. Difatti – per Heidegger – il tempo non può definirsi né soggettivo né oggettivo poiché l’unico tempo del Dasein è il tempo dell’esistenza. Questo concetto è chiaro nella lotta alla sopravvivenza dei quattro androidi ma diventa anche un riflesso per lo stesso Deckard, che lentamente riscopre l’importanza del vita e del suo limite temporale.
“Blade Runner è una riflessione su cosa significa essere vivi. I replicanti non sono macchine… sono più umani degli umani.” – Ridley Scott
Autenticità VS Inautenticità

L’ultimo concetto di questa analisi ruota attorno alla distinzione tra autentico e inautentico in Heidegger. Secondo il dizionario italiano, “autentico” è ciò che è vero o non imitato — ma per Martin Heidegger la questione è più profonda: l’autenticità è strettamente legata al concetto di essere. È autentico, infatti, chi vive nella consapevolezza della propria finitezza, chi riconosce la morte come possibilità costante e sceglie di vivere in base a questo, anziché lasciarsi trascinare dai costrutti sociali o dall’inerzia della quotidianità. La coscienza, dunque, non è più morale, ma ontologica: il Dasein conquista la propria autenticità.
Deckard, da individuo distaccato, passivo e disilluso, evolve lentamente in un essere autentico, chiamato a confrontarsi direttamente con la morte e con la propria coscienza attraverso la caccia ai replicante e il rapporto con Rachael, un androide di ultima generazione convinta di essere umana. Ma Rachael non è convinta tanto di essere composta di carne ed ossa quanto di essere autentica, ed è proprio questo a renderla umana. Pensare alla propria finitezza, relazionarsi agli altri (ad esempio il legame con Deckard) e scegliere di vivere secondo propria volontà (la fuga finale), sono tutti elementi che rendono Rachael davvero umana e nei quali Deckard si rispecchia. In questo modo, Blade Runner supera la semplice contrapposizione tra umano e non-umano, concentrandosi invece sulla dicotomia autentico/inautentico.
Il monologo finale è stato improvvisato dallo stesso Rutger Hauer, emozionando l’intera troupe durante le riprese.
Il simbolo più riuscito di questo concetto è comunque rappresentato da Roy Batty durante il celebre monologo finale del film. Spinto dalla consapevolezza della sua imminente fine, Batty raggiunge una pienezza d’essere che culmina nel gesto più umano e compassionevole possibile: un gesto di pietà. Batty risparmia Deckard, accettando la propria morte e recitando le memorie che definiscono la sua essenza – la sua vita come frammenti di tempo – congedandosi dalla vita in modo autentico e diventando un monito per Deckard. Blade Runner ci invita allora, oggi più che mai, a chiederci cosa significhi davvero essere reali — e se, forse, non siano proprio le macchine a ricordarcelo meglio di noi.