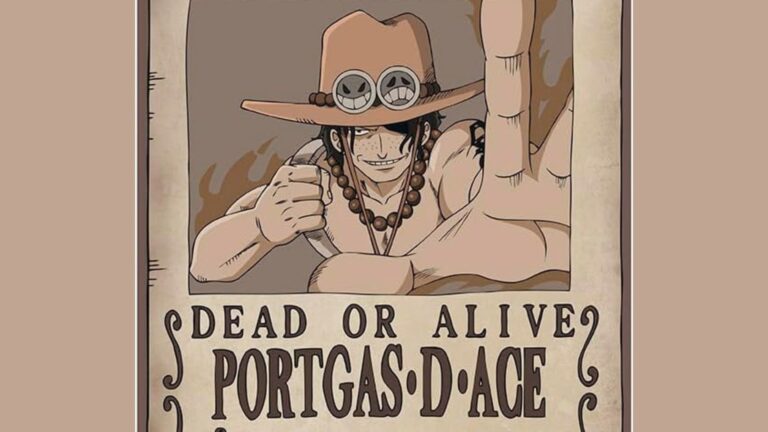Sono 26 anni che Eiichirō Oda ha mollato gli ormeggi e nel tempo, su quella barca chiamata One Piece, ci siamo saliti tutti. Qualcuno ha deciso di diventare parte integrante della ciurma, altri hanno solo condiviso un tratto della propria rotta con quella di Luffy e compagni. Una storia editoriale e poi multimediale senza precedenti ed era quindi solo una questione di tempo prima che ne arrivasse una trasposizione in live action. Un passaggio delicato e molto temuto, non a torto visti i precedenti con le trasposizioni di questo tipo. Si sentirà lo spirito d’avventura? Avranno rispettato la natura dei vari personaggi? Saranno stati in grado di replicare l’atmosfera tipica della ciurma?
Il 31 agosto la serie di One Piece è approdata su Netflix, ha risposto a tutte le nostre domande e ha ricordato i motivi per cui, negli anni, ci siamo innamorati del manga di Oda.
Il coraggio di riadattare

La serie di One Piece ha capito che per poter veicolare lo spirito dell’opera originale doveva prima di tutto tradirla. O meglio, per poter esprimere quel sentimento di libertà emanato dalle pagine del manga, doveva divincolarsi dalle catene della fedeltà tout court. Anche perché un adattamento in live action comportava da una parte la necessità di trovare un linguaggio nuovo e per forza di cose più vicino alla realtà. Dall’altra un potenziale nuovo pubblico, magari non a suo agio con certi vezzi tipicamente orientali. Ci sono modifiche estetiche, come la decisione di non applicare a Usopp una protesi per il naso o di mettere delle scarpe e non dei sandali a Luffy. C’è un cambiamento nei toni che smussa le esagerazioni tipiche di uno shonen manga, ovvero un manga con target adolescenziale.
E poi c’è il piano narrativo. Questa prima stagione adatta i primi 11 volumi dell’opera di Oda e con un tempo a disposizione inferiore alle 8 ore ha dovuto, per forza di cose, comprimere tempi e asciugare il racconto. Viene a patti con il linguaggio cinematografico e con la struttura di una serie tv, creando archi narrativi – come quelli di Kobi e Garp – differenti rispetto all’originale ma adatti a un prodotto di questo tipo. Insomma, le modifiche sono svariate. E apportare dei cambiamenti così evidenti alla trasposizione del manga più venduto di sempre è una dimostrazione di grande coraggio.
Rispettare i personaggi

Questa serie, come dicevamo, ha un target diverso rispetto al manga, tendenzialmente più maturo. Di conseguenza sono stati fatti piccoli cambiamenti anche ai personaggi. Luffy ha un approccio complessivamente meno ingenuo e, dietro ai suoi occhi, più che l’esagerata spensieratezza della controparte cartacea si nasconde una folle determinazione. Sanji è smussato di tutta quella parte legata al rapporto con l’altro sesso e reso complessivamente più cool. Il ruolo da bugiardo guascone di Usopp è rispettato ma alle spalle di quel mondo di menzogne si nasconde un’accentuata e profonda malinconia.
Poi ci sono loro: Zoro e Nami.
Il vero motore di questa prima stagione di One Piece. Sono la bussola morale di tutta la narrazione, l’appiglio con il quale la serie cerca di fare un passo avanti in termini di maturità rispetto al manga. Adolescenti con vizi e passioni ma che nascondono un passato tragico che li ha inevitabilmente segnati. Eppure tutte queste – più o meno grandi – differenze, mostrano un profondo rispetto verso il manga. Guardando la serie di One Piece, esattamente come quando leggiamo le pagine inchiostrate da Oda o approcciamo l’anime di Toei, ci sentiamo parte della ciurma. Una famiglia che abbiamo scelto.
Il diritto alla libertà ed a inseguire i propri sogni

One Piece non è mai stata un’opera come le altre. Certo, come battle shonen ha caratteristiche che lo accomunano ad altri manga dello stesso genere. Gli scontri, il tono a tratti infantile, i power-up. Eppure ha sempre avuto qualcosa in più. Oda ha saputo costruire nel tempo, come nei migliori fantasy, una serie di sovrastrutture che hanno portato il suo mondo ad avere: una storia, una mitologia, degli accenni di cosmogonia, una piramide di potere ben definita, delle istituzioni – più o meno corrotte – e delle diversificazioni culturali in base al territorio. In questo contesto ha preso i suoi personaggi e ha dato vita a un’avventura.
In One Piece il viaggio non ha un vero e proprio obiettivo finito come potrebbe essere nel fantasy tolkeniano. Tant’è che il punto di approdo finale è il fantomatico One Piece, un qualcosa che ancora oggi nessuno, a distanza di 26 anni dall’uscita del primo capitolo, ha idea di cosa rappresenti. È il viaggio per il giusto di viaggiare, per la voglia di vedere cosa si nasconde in quell’isola apparsa all’orizzonte. Per scoprire nuove culture, per assaggiare nuovi cibi, per fare nuove amicizie. Un approccio talmente libero che spinge a combattere ogni forma di schiavitù.
Che si tratti di un’imposizione sociale o di una condizione mentale non importa: sono catene che vanno spezzate. In One Piece, quella di Luffy e di tutti i suoi coetanei è considerata una generazione in grado di cambiare lo status quo. Di rompere la ruota, come si direbbe in Game of Thrones. Ma a differenza dei personaggi di Martin, nessuno nell’opera di Oda ha quello come obiettivo. È una naturale conseguenza del loro essere liberi. Ed è una libertà che nasce da un qualcosa di ancora più astratto ma che contemporaneamente è visto come un diritto inalienabile: il diritto ad inseguire il proprio sogno.
Un concetto complesso, che porta con sé un profondo scontro generazionale tipico del Giappone di fine anni ’90 ma che ha un valore talmente universale da aver fatto presa, nell’arco di tre decenni, su tutto il mondo. Ed il fatto che in sole 8 ore la serie di One Piece ci abbia fatto percepire così nitidamente questo diritto alla libertà e di inseguire i propri sogni è il più grande successo che il progetto targato Netflix potesse raggiungere.