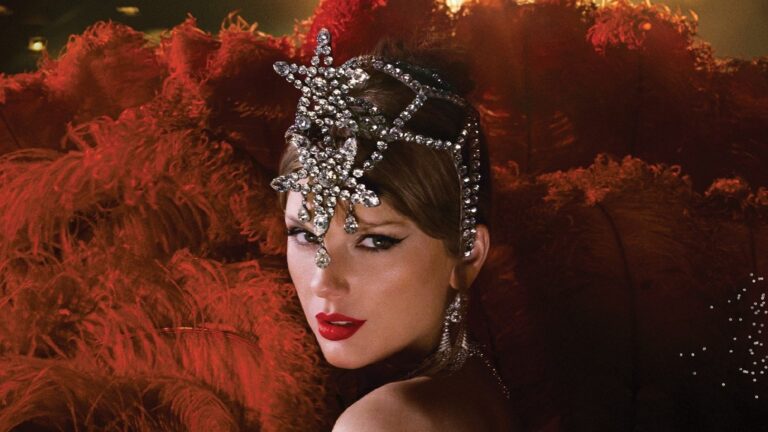Il Nobel per la pace ha sempre avuto un rapporto complicato con la realtà. Mentre il comitato norvegese si prepara ad annunciare il vincitore del 2025, il dibattito si accende attorno a una candidatura che ha del paradossale, quella di Donald Trump. Il presidente americano ha rilanciato con forza la sua aspirazione al prestigioso riconoscimento dopo l’accordo su Gaza, trovando sostegno persino dal presidente israeliano Isaac Herzog, che ha dichiarato su X la sua “infinita gratitudine” e l’auspicio che Trump meriti il premio “per la sua costante determinazione a porre fine alla guerra“.
La proposta ha suscitato reazioni immediate anche in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato su RTL 102.5, ha ammesso che l’idea “sembrava una boutade qualche mese fa” ma che ora, dopo l’intesa raggiunta, “certamente i titoli li avrebbe“. Anche Matteo Salvini si è accodato, definendo “una notizia stupenda” il possibile rilascio degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco, concludendo che Trump “merita davvero il Premio Nobel per la Pace“. Ma quanto è credibile questa candidatura? E soprattutto, quanto è coerente con la storia stessa del premio? La risposta richiede un tuffo nel passato, tra precedenti imbarazzanti e contraddizioni clamorose che hanno segnato l’assegnazione del Nobel per la pace ai leader americani.

Dalla nascita del Novecento fino a oggi, sei figure legate agli Stati Uniti hanno ricevuto il Nobel per la pace: quattro presidenti, un vicepresidente ambientalista e un segretario di Stato simbolo della realpolitik. In ciascuno di questi casi, le motivazioni ufficiali sono state accompagnate da obiezioni pesanti, quando non da autentiche controversie. Theodore Roosevelt fu il primo presidente americano premiato, nel 1906, per aver mediato la fine della guerra russo-giapponese con il Trattato di Portsmouth. Un conflitto sanguinoso risolto grazie alla diplomazia di un’America emergente come potenza globale. Tuttavia, l’immagine del pacificatore cozzava frontalmente con la sua celebre filosofia del Big Stick: parlare dolcemente impugnando un grosso bastone. Roosevelt era infatti il simbolo dell’espansionismo americano, artefice del Canale di Panama e protagonista delle occupazioni coloniali di Cuba e Filippine.
Woodrow Wilson ottenne il riconoscimento nel 1919 per aver fondato la Società delle Nazioni, il primo tentativo di creare un’organizzazione multilaterale per la pace dopo la Grande Guerra. Un’intuizione visionaria che teorizzava un nuovo ordine mondiale basato sul diritto internazionale. Peccato che l’organizzazione nascesse senza gli Stati Uniti: il Senato di Washington rifiutò di ratificarne l’adesione, trasformando il sogno di Wilson in un fallimento immediato.

Ma è con Henry Kissinger che il Nobel per la pace raggiunge il suo apice di contraddizione. Nel 1973, il segretario di Stato di Richard Nixon fu premiato insieme al nordvietnamita Le Duc Tho per gli accordi di Parigi che avrebbero dovuto mettere fine alla guerra del Vietnam. Tho rifiutò il premio, definendolo una farsa, e aveva ragione: pochi mesi dopo il conflitto riesplodeva. Kissinger, architetto della realpolitik al culmine della guerra fredda e artefice del dialogo con la Cina di Mao, restava indissolubilmente legato ai bombardamenti in Cambogia e Laos, al sostegno al golpe in Cile. Un Nobel che ancora oggi è considerato uno dei più contestati della storia.
Jimmy Carter dovette aspettare oltre vent’anni dalla fine della sua presidenza per ricevere il premio, nel 2002. Nel frattempo aveva costruito il Carter Center come laboratorio di mediazione internazionale e lotta contro le malattie in Africa. Durante il suo mandato aveva mediato lo storico accordo di Camp David tra Egitto e Israele. Eppure anche quel Nobel fu un gesto politico, un messaggio anti-Bush in piena guerra al terrore. I detrattori non mancarono di ricordare la sua ingenuità moralista e la crisi degli ostaggi in Iran che aveva segnato la fine della sua carriera politica. Al Gore, vicepresidente di Bill Clinton sconfitto da George W. Bush nel 2000, ricevette il premio nel 2007 insieme all’IPCC per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Il suo documentario “”An Inconvenient Truth”” aveva collegato il clima alla sicurezza e alla pace globale. Ma il comitato di Oslo venne accusato di attivismo politico eccessivo e di premiare le intenzioni. Un tribunale britannico segnalò nove errori di interpretazione nel film, mentre gli avversari sottolineavano l’ipocrisia di Gore, che viaggiava su jet privati e aveva interessi finanziari in fondi verdi.

Barack Obama rappresenta forse il caso più eclatante. Ricevette il premio nel 2009, appena nove mesi dopo il suo insediamento, “per i suoi straordinari sforzi nel rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli“. Un Nobel che intendeva premiare la promessa di un’America riconciliata con il mondo dopo gli anni di Bush. Ma Obama accettò il premio mentre le truppe americane combattevano in Afghanistan e i droni colpivano in Pakistan e Yemen. Lo stesso presidente ammise di non meritarlo, almeno non ancora. Negli anni successivi avrebbe autorizzato campagne militari in Libia e Siria e le controverse “esecuzioni extra-giudiziali” di presunti jihadisti con droni e missili, senza processo, in Paesi con i quali gli Stati Uniti non erano formalmente in guerra.
Questo lungo elenco di contraddizioni riduce il Nobel per la pace, con estremo cinismo, a una sorta di concorso di popolarità geopolitica. La giuria norvegese ha spesso premiato non tanto i risultati concreti quanto le intenzioni, i simboli, le speranze di un cambiamento che non sempre si è materializzato. In molti casi, il premio è stato uno strumento politico per mandare messaggi all’opinione pubblica mondiale o per influenzare gli equilibri internazionali. La candidatura di Trump si inserisce in questo contesto ambiguo. Se l’accordo su Gaza dovesse effettivamente portare al rilascio degli ostaggi israeliani, al cessate il fuoco e alla ricostruzione della Striscia, Trump potrebbe rivendicare un risultato diplomatico significativo. Ma il percorso verso quel traguardo è disseminato di incognite, e la storia insegna che le intese in Medio Oriente sono fragili quanto le promesse elettorali.