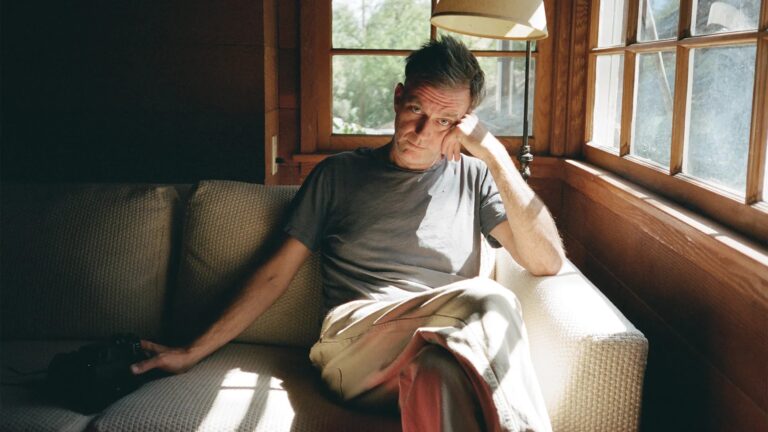Paolo Sorrentino, uno dei registi più dibattuti in terre nostrane, fra chi non lo apprezza per i troppi orpelli altisonanti, la patina perpetua e chi lo ama per la capacità di narrare la solitudine umana, trasformare il proprio/nostro dolore attraverso la cinepresa.
I film di Sorrentino sono appuntamenti con i ricordi – formulazione utilizzata dallo stesso regista nel contributo Netflix a proposito dei suoi ambienti d’infanzia – in una ricerca costante di qualcosa di inafferrabile.
Interminati spazi

Nel cinema, come nei sogni, c’è una sorta di testo manifesto che cattura l’attenzione dell’osservatore. L’immagine, i colori, la trama, i personaggi, le loro storie. Ci perdiamo nella catena di sfumature di chi ha pensato l’opera, nella superficie di qualcosa di chiaro che viene impresso attraverso scrittura, pittura, cinema, musica o qualsiasi altra fabbrica di fantasia. Una volta toccato il primo strato della matriosca, possiamo tentare di agganciare il significato-oltre di ciò che abbiamo visto, letto o sentito, che non coincide con il solo scopo di perdersi in mere interpretazioni capaci di arricchire l’esperienza visiva appena conclusa.
La danza delle parole della prosa o della poesia, per esempio, imprime a ogni vocabolo scelto un suono preciso pescato nell’inconscio. Fa breccia in un’esperienza che costruisce, decostruisce e trasforma e conduce verso i celebri interminati spazi, in un universo che punti verso l’oltre. Antonio di Benedetto parla di quanto l’artista abbia il privilegio di vedere la crescita e la trasformazione della sua opera via via che le dà spessore, identità, ma che conoscerà davvero solo una volta data alla luce. Pertanto, la produzione artistica e la sua conseguente trasformazione è un’operazione costante che trova sede nel momento in cui si pensa all’opera, si costituisce e prosegue quando si pone dinanzi al mondo, usufruendone.
E allora, l’arte si palesa come una nascita creativa che libera, si collega al dolore psichico dell’individuo, alla sua angoscia, al senso di colpa celato, ai processi di vuoto e attraverso la stessa arte ripara – o tenta di – il trauma che ha generato la sofferenza.
“’O tieni nu dolore?”

Per spirito di autoconservazione, l’uomo è spinto a non provare dolore e viaggia alla ricerca di dare una connotazione, un nome e un cognome al proprio stato, tentando di circoscriverlo e collegarlo alla propria storia. A volte, però, deve fermarsi nella sua ricerca spasmodica e pensare che questo senso non necessariamente sarà costruibile, che esiste la possibilità che il dolore non abbia l’opportunità di essere delimitato.
Allo stesso tempo, quando parliamo di dolore parliamo inevitabilmente anche di vita. Un uomo senza dolore è un soggetto senza memoria, senza identità, come afferma anche Goriano Rugi (per chi volesse approfondire, Trasformazioni del dolore). Il dolore, pertanto, è costitutivo dell’esistenza dell’uomo, fa parte di esso e ne caratterizza la sua evoluzione e la sua vitalità. L’individuo nasce proprio nel e con il dolore, venendo al mondo urlando, sia per una ricerca di sopravvivenza respiratoria, sia, metaforicamente, per aver abbandonato quel luogo caldo e accogliente.
La nascita, infatti, è intrecciata in un rapporto simbiotico con il vissuto del dolore rappresentato già in un primo movimento di strappo dal ventre materno, da un taglio, una ferita che implica una perdita. Perdita che sarà costante nel corso della vita, a ogni tappa, in termini reali, simbolici, identitari. In questo senso, il cinema di Sorrentino, per sua stessa ammissione – “la realtà è scadente” – assume un processo quasi schizoide, in cui la fantasia funge da rifugio massimo e mondo dei rapporti umani, a discapito della realtà tangibile, troppo spinosa. Trova conforto nel bacino dell’immaginazione, fuori dal rumore stentoreo del dolore umano e, citando il regista, necessita di noia.
“Non ti disunire”

È piuttosto automatico notare quanto tutto questo, nelle opere sorrentiniane, si intersechi con il tema della perdita, generando uno degli assi portanti e declinandosi poi in senso di vuoto, tristezza, solitudine, potere effimero, divinità Possiamo cercare di dissociarlo, scacciarlo, rimuoverlo con operazioni mentali consce o inconsce che siano, ma l’unica modalità per superare il trauma della perdita dell’Altro o di parti di sé è proprio quello di non disunirsi. Non andare in frantumi, non tradire sé stessi, avvicinarsi al proprio fallimento e al proprio dolore, perché questo, paradossalmente, non è un nemico acerrimo da sconfiggere, ma una risorsa vitale per rinascere.
Aldo Carotenuto, uno dei più importanti psicoanalisti di questo Paese, parlava di ferita feritoia, proprio per delineare l’importanza di poter scrutare dentro le nostre sofferenze come un pertugio, non trasformandole in cicatrici da collezionare, ma in spazi di osservazione di sé. Un dolore da riconoscere – “non ti hanno lasciato solo, ti hanno abbandonato” – che ha bisogno di accettazione e soprattutto di consapevolezza del cambiamento che porterà.
Non perderti, ritrovati.
“La cosa peggiore che può capitare a un uomo che trascorre molto tempo da solo è quella di non avere immaginazione”

Eugenio Borgna, nel suo saggio In dialogo con la solitudine, ci ricorda quanto la solitudine nasca dall’interiorità e consenta di dare un senso alla vita, distinguere ciò che è essenziale, da ciò che non lo è. È lo scarto in cui nasce la relazione, l’opportunità di aprirsi all’altro, donarsi e identificarsi con il vissuto altrui.
Titta Di Girolamo vive nell’immobilismo più radicale, scandito da abitudini marmoree, in un’esistenza priva di ogni particella sensoriale e connotata da un profondo senso di morte. Jep Garbadella ha smarrito il senso di sé una volta perso lo sguardo verso la purezza ed essersi immerso sotto il bla bla bla della grande menzogna. È l’uomo delle feste, che partecipa a trenini effimeri, perché lui è Nessuno – come gli ricorda la piccola Francesca. Una lotta costante fra chi sente di essere e chi mostra di essere (una sorta di duello forse fra Vero Sé e Falso Sé) che solo attraverso la morte riuscirà a districare. I monologhi di Andreotti e Tony Pisapia raccontano verità scomode custodite nella solitudine più innestata.
La stessa acuta analisi viene riservata a personaggi ancora più soli, come Berlusconi. A Sorrentino non bastano i tratti narcisistici e istrionici visibili agli occhi di tutti, la coperta di scacchi politici o la brillantezza dei rotocalchi davanti allo scandalo nostrano. Il ritratto è quello di un uomo estremamente solo, un venditore guardone dei fuochi d’artificio che lo accerchiano, ma che al contempo sono pronti a girarsi altrove appena possibile. Infatti, come anche Valdré sottolinea, riprendendo Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Freud spiega come il soggetto si identifichi con il leader e sostituisca il proprio ideale dell’Io con quello del capo. La massa vive come in una sorta di bolla ipnotica, in cui dipende dall’altro con tratti di regressione, in un amore reciproco – non dimentichiamoci le risposte della folla dinanzi a Mussolini. Ecco, questo, con l’uomo-cavaliere di Sorrentino, non accade.
“Perché le radici sono importanti”

Tutto il cinema di Sorrentino, alla fine dei conti, si gioca sulla ricerca di radici. Lentamente e a tratti alterni, il regista si avvicina sempre più a Napoli, raggiungendola definitivamente con È stata la mano di Dio, film più intimo nel contenuto manifesto, e Parthenope.
Perché le radici, oltre a consentire una solida stabilità, permettono il nutrimento e di tornare a sé, a ciò che di più autentico abbiamo avuto – motivo per cui anche l’anzianità fa da protagonista. Titta Di Girolamo, sul finire delle sue ore, si rivolge a Dino Giuffré, l’amico di sempre, che richiama alla memoria l’importanza dell’amico del cuore tanto caro alla psicoanalisi di Sullivan; Jep Garbadella recupera il desiderio scavando sotto la coltre della nullità; Fabietto si illude di poter trovare riparo fuori dalle pendici del Vesuvio, ma tornerà alle origini, in qualità di Paolo Sorrentino, per ritrovarsi; Parthenope, superati gli sguardi desideranti, incontra la semplicità di chi va custodito con cura, perché fatto di acqua e sale.
Le parole che tracciano la linea delle radici e dunque anche dell’abbandono si mescolano alla fede, come la Santa da una parte e Papa Pio XIII dall’altra. Figure vicine (teoricamente) alla linea del Paradiso, che incarnano il potere spirituale, paradossalmente quasi divini nella loro sfacciata umanità, in cui ricongiungere il senso di morte percepito a quello della vita.
La nostalgia di un tempo perduto

Ma la perdita in Sorrentino e dunque il ritorno alle radici sono connotati soprattutto da un sentimento di nostalgia, contraddistinta da una perdita mai definitiva.
Come ricorda Recalcati (La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia), il lavoro del lutto dovrebbe condurre all’accettazione finale della perdita, tranne nei casi in cui prevale un vissuto melanconico, in cui assistiamo a una specie di congelamento della condizione e un’identificazione con l’oggetto venuto a mancare. Quando la perdita, però, si aggrappa al sentimento della nostalgia, accade qualcosa per cui la presenza dell’altro si ripresenta costantemente, nella quotidianità, nella memoria. Si tratta di una presenza assidua nell’assenza, l’illusione viva di appuntamenti con i ricordi dal sapore di Aspettando Godot, che quando diventando consapevolezza della perdita possono condurre solo alla distruzione – il lasciarsi andare del fratello di Parthenope.
La nostalgia porta lo sguardo del soggetto verso i luoghi del passato, verso la propria origine e questo conduce a una sensazione di mancanza, esattamente come nel sentimento nostalgico dell’amore perduto. La nostalgia implica il fantasma del ritorno, il rivisitare l’infanzia, le origini. Implica tornare verso un materno – forse non a caso, l’elemento dell’acqua, simbolo associato spesso al materno appunto, appare di gran lunga – da cui siamo stati separati con la prima ferita della nascita e successivamente da ogni passo verso l’individuazione. E mentre ci facciamo spettatori del tentativo di recuperare queste parti perdute, assistiamo a un desiderio che non verrà mai appagato realmente e che per questo motivo prenderà la forma di una ricerca di qualcosa di inafferrabile.
Lui, Loro, Noi, Tutti

La ricerca di Sorrentino ha il potere di impastarsi con quella di chi partecipa, sono due voci di una stessa melodia che si sintonizzano, esattamente come un’analisi terapeutica. Un impasto di buchi bianchi – metafora utilizzata da Marina Breccia in Contro-tempo – da cui non è possibile evacuare niente. Stesso destino di un dolore verbalizzato o meno di un paziente in seduta – Panizza ricorda “quando il paziente soffre, io soffro” – ossia nella possibilità di abbandonarsi a un vissuto di identificazione con ciò che il paziente vive, posizionandosi in una sintonizzazione completa con lui, ma al contempo di rimanere fuori dal bordo del fiume della relazione.
Il cinema di Sorrentino è una sintesi difensiva piuttosto accurata. La sua essenza è ben nascosta dalla cura estetica, che protegge la poetica che si cela sotto il tono di ogni parola scelta. Una poetica che, come abbiamo tentato di raccontare, è vuota e desiderante allo stesso tempo. Accediamo a un mondo privato, tutelato da frasi a effetto, ma in cui prevale la nostalgia del perduto. E questo, a ben guardare, può valere per tutti noi.